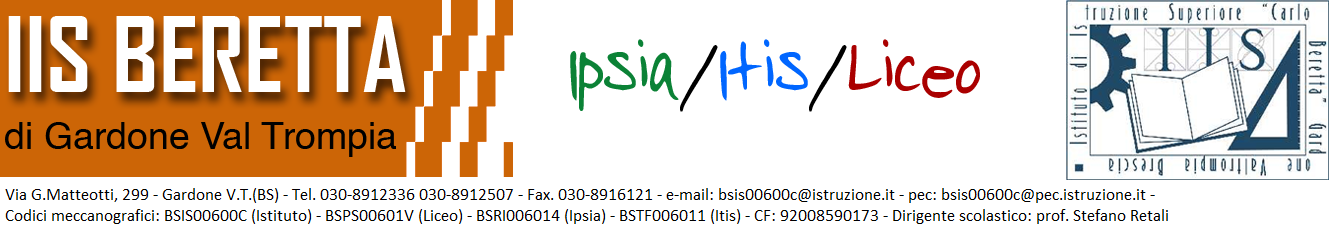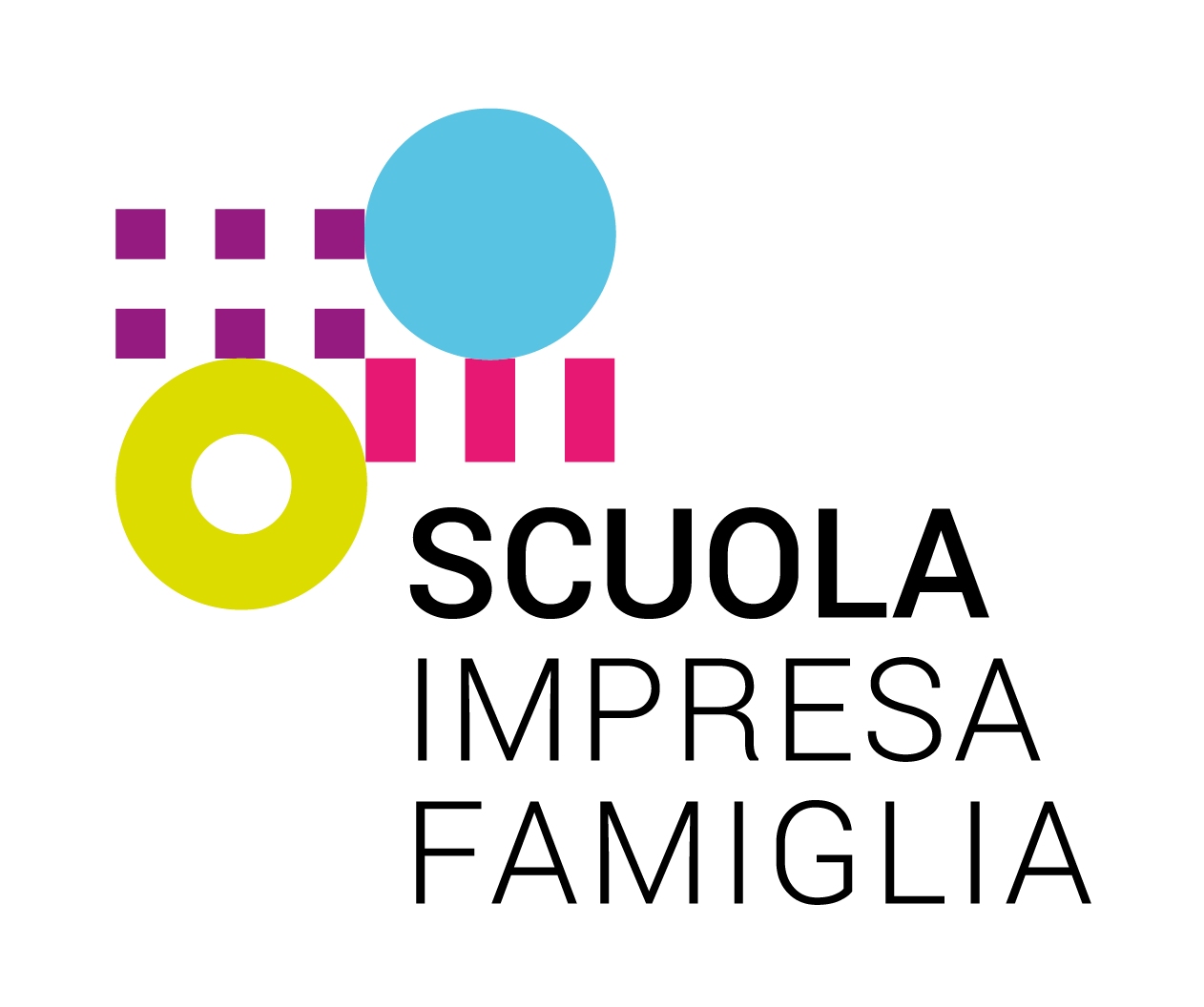Tra Seconda Guerra mondiale ed esodo dalmata
- Dettagli

Tra Seconda Guerra mondiale ed esodo dalmata: memoria presente tra i nostri alunni. Quando la collaborazione scuola – famiglia fa lezione di Cittadinanza e memoria attiva
Mia Nonna è nata il 27 marzo 1936 a Nimis (UD), un piccolo paese vicino al confine sloveno (Ex Jugoslavia).
L’apice della guerra arriva nel paese di mia nonna nel 1944. Dopo aver vissuto un periodo di difficoltà economiche dovute alla guerra stessa, scarsità di cibo, carenza di strutture pubbliche quali ospedali, scuole… la guerra arriva in paese con l’occupazione da parte dei “cosacchi” per il controllo del territorio in sostituzione ai tedeschi.
Già da due anni, una parte della popolazione italiana, iniziava ad organizzarsi diversamente da quella che era l’alleanza con la Germania. Con la formazione di bande partigiane vengono a formarsi le brigate Osoppo e Garibaldi, in queste organizzazioni si potevano arruolare uomini di tutte l’età, tra questi c’erano anche ragazzi molto giovani di 15 anni circa, come un cugino di mia nonna o come il papà che aveva 44 anni.
I tedeschi, dopo i fatti dell’otto settembre, invadono l’Italia e per tenere il controllo di alcune zone del Friuli Venezia Giulia utilizzano i cosacchi. I tedeschi avevano promesso ai cosacchi che vincendo la guerra il Friuli sarebbe rimasta la loro terra in cui vivere. I cosacchi accettarono, in quanto essendo “zaristi” sarebbero stati eliminati dai russi se avessero fatto ritorno in patria e pertanto si erano rifugiati in Germania, la quale li aveva accolti e dato loro quest’ultimo compito di occupazione. I cosacchi avevano il compito di tenere il presidio nei paesi del Friuli ove erano presenti partigiani. Come ricorda mia nonna, i cosacchi vivevano in gruppi familiari e alloggiavano in carovane, erano mal armati dai tedeschi, con armi di scarto e spesso mal funzionanti, erano soliti saccheggiare le case per procurarsi cibo e quant’altro. Tra vari ricordi di mia nonna legati a quel periodo c’è il posizionamento di un cannone di fronte a casa sua, utilizzato da dai mongoli, anche essi associati ai tedeschi, che sparava contro la Ex Jugoslavia di “Tito”. I bambini, compresa mia nonna, stavano a guardare la partenza delle cannonate fino a che i genitori non li richiamavano in casa. Un altro ricordo importante di mia nonna fu quando sua mamma e una zia mentre stendevano al sole la biancheria ed essendo la casa situata vicino ai boschi, i cosacchi pensarono che la stesura dei panni fosse segnalazioni ai partigiani. Per questo fatto furono messe alla fucilazioni, se non che un cosacco siccome più volte si era fatto fare da queste donne lavori di sartoria risparmiò loro la vita non facendole fucilare.
I partigiani vivevano tra i boschi, ed erano al corrente di come i cosacchi si comportavano in paese, di conseguenza decisero di unire le due fazioni (Garibaldi e Osoppo) per avere la forza militare di scacciarli. I partigiani riuscirono nell’impresa e i cosacchi furono costretti a scappare e abbandonare Nimis, Attimis e Faedis i tre paesi principali situati in confine con la Ex Jugoslavia e che per la loro vicinanza a colline e zone boschive favorivano lo stanziamento di partigiani in gran numero, perché qui riuscivano meglio a nascondersi. I tedeschi, molto ben organizzati militarmente, dopo avere inutilmente tentato di bloccare la ritirata dei cosacchi, immediatamente inviarono i rinforzi dal comando che era situato a Trieste. Nel giro di poco tempo arrivarono nei tre paesi. Evacuarono i paesi sopra citati, incolonnarono tutta la popolazione e all’uscita dei paesi furono selezionati i giovani, i maschi portati nei campi di concentramento, le donne nelle fabbriche tedesche per la costruzione di bombe, in quanto fabbriche pericolose utilizzavo i prigionieri. In un primo momento pensavano di deportare tutti in Germania nei campi di concentramento, in seguito decisero che la gente anziana e i giovanissimi, venissero liberati e detto loro di andarsene, allo stesso tempo vennero bruciati i paesi compresi stalle piene di animali e foraggi, dando la possibilità alla gente di raccoglie oggetti personali che potessero essere trasportati autonomamente.
Nella deportazione in Germania nei campi di concentramento, mia nonna ricorda il proprio zio che morì poco dopo a “Dachau”. Una sola persona di Nimis si salvò dal campo di concentramento, si trattava di un giornalista che raccontò poi in futuro queste vicissitudini. Durante il periodo nel quale i tedeschi erano stanziati nei tre paesi, la gente del posto come racconta mia nonna doveva andare in giro vagabondando per i paesi limitrofi, elemosinando e cercando alloggio e qualcosa da mangiare.
Di quel periodo mia nonna ricorda quando lei sola, in quanto le altre due sorelle erano ancora troppo piccole, e sua mamma, raggirarono il paese e i cosacchi presenti, per recarsi alla loro abitazione per vedere ciò che era rimasto dopo l’incendio. Trovarono la distruzione di tutte le abitazioni e vicino casa poterono vedere un cadavere semi sepolto di un omonimo del padre della famiglia in quanto era ricercato perché faceva parte della brigata Osoppo. Il nonno fu in seguito preso in altri rastrellamenti, fu fatto prigioniero e messo alla fucilazione se non che un tedesco presente lo riconobbe come carceriere in un'altra occasione, e ricordando come fu trattato da prigioniere riuscì a liberarlo.
Questo stile di vita durò all’incirca un anno, fino alla fine della guerra in aprile del 1945. Per quanto fosse finita la guerra i problemi nel Friuli non cessarono. La gente precedentemente evacuata iniziò il rientro nei paesi precedentemente bruciati. Iniziò la ricostruzione delle case civili. La Svizzera, in questa emergenza, fornì delle baracche per poter far vivere le persone il più possibile vicino alle zone lavorative. I problemi rimasero per il confine con Tito, il quale, essendo vittorioso su di noi italiani, e avendo aiutato molto la zona del Friuli con i suoi partigiani per sconfiggere i tedeschi, pretendeva di portare il suo confine fino al fiume Tagliamento, ovvero gran parte del Friuli. Per quanto questo non accadde mai, la paura che accadesse in quegli anni era molta. Fin a che non si arrivò al 1954 con il trattato di “Osimo”, lo Stato per paura di dover concedere il territorio e le eventuali industrie, proibì lo sviluppo nel Friuli e così tolto case civili non si poteva costruire fabbriche per dar lavoro alla gente del posto. Molte persone non avendo lavoro furono costrette ad emigrare. Nella famiglia di mia nonna il primo ad emigrare fu il padre, dopo di che fecero lo stesso le tre figlie in ordine con il raggiungimento dei 18 anni, età minima per essere accettati a lavorare in svizzera. Mia nonna e le due sue sorelle lavorarono in Svizzera in una fabbrica che produceva dei pezzi di automazione.
Per quanto le cose potessero andare bene la ricostruzione di questi tre paesi rasi al suolo dagli incendi fu fatta senza tener conto del fatto che si trovassero in zona sismica, e nel 1976 il Friuli fu duramente colpito dal terremoto e questi tre paesi furono nuovamente distrutti. Mia nonna si trovò al di fuori di tutto ciò perché da emigrata incontrò mio nonno, anche esso emigrato in svizzera per non dover lavorare in miniera. Nel corso degli anni si sposarono ed ebbero un figlio. Rientrarono in Italia visto che le prospettive di lavoro erano migliorate, intrapresero un’attività commerciale, gestirono una pensione a Collio Val Trompia paese di origine di mio nonno, zona che ai tempi era turistica per via del grosso successo di una stazione sciistica.
Edalini Marco 5B
27 gennaio, una riflessione
- Dettagli

27 gennaio. Un ricordo di liberazione, un ricordo di dolore.
27 gennaio 1945, nel campo di concentramento di Auschwitz si respira libertà e speranza, ma gli occhi dei pochi sopravvissuti sono vuoti, un vuoto ricolmo di rabbia, dolore, rancore, sofferenza.
Sembrava un giorno come tanti, quel 27 gennaio 1945, l’ennesimo giorno di lavoro, di fatica, di morte, l’ennesimo tentativo di arrivare alla sera, l’ennesimo tentativo di non ascoltare l’assordante voce della coscienza che ti chiede urlando e piangendo se vale davvero la pena scegliere ogni giorno la sopravvivenza invece di una morte liberatoria. È l’unico pensiero della giornata; il resto è vuoto.
Del resto, un numero non dovrebbe pensare, dovrebbe solo lavorare, il lavoro rende liberi, Arbeit Macht Frei. Il massimo che potrebbe fare un numero è morire: di sete, di fame, di stanchezza, di dolore, di malattia, nelle camere a gas, fucilato, squartato. Ma non può permettersi di essere umano, un numero. Un numero non ci somiglia neanche, a un essere umano.
Poi una macchia scura all’orizzonte scombussola l’ordinario. Si avvicina sempre più. Un confuso silenzio. Da un’anima stanca e debole prorompe un urlo rauco: “Sono venuti a liberarci, siamo liberi, siamo liberi!”. Eccola, la speranza, una stilla di speranza in quella fiammata di morte.
Nel campo eravamo rimasti solo noi, i deboli, i malati. Gli altri se li sono portati via i nazisti. Probabilmente sono morti.
Le porte di Auschwitz si aprono, l’orrore si riversa nel mondo.
Come farete, ora, a guardarci negli occhi? Come pretendete di capire?
Siamo morti. Siamo morti perché eravamo ebrei. Eravamo innocenti, dottori, insegnanti, bambini, mogli, mariti, bibliotecari, umani, ma ebrei: la nostra unica colpa, la riposta sbagliata a una domanda ingiusta, ma dov’è, in fondo, la giustizia? Dov’è il bene? Cos’è il male?
Siamo sopravvissuti. Siamo sopravvissuti all’inferno. Come pensate che torneremo, ora, alla nostra vita di sempre? Non esiste più la nostra vita di sempre.
Arbeit Macht Frei.
Sono un numero. Sono solo. Non ho più nessuno. Sono tutti morti.
Sono tutti morti.
Dov’era il mondo, mentre milioni di ebrei venivano sterminati dalla follia? Dov’eravate, quando ci torturavano, quando ci squartavano, quando avremmo voluto solo vivere, quando avremmo voluto solo sentirci umani?
Un orrore commesso da un uomo, da una nazione, dall’umanità.
Un orrore che non può essere dimenticato, chi dimentica è complice. Un orrore che non possiamo permetterci di ripetere. “Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore”. Una richiesta, un dovere, un ordine impossibile da ignorare.
Almeno una volta all’anno, un giorno all’anno. Il 27 gennaio si ricorda. Il 27 gennaio si insegna. Un avvertimento al futuro. Parlate, informatevi, raccontate, leggete, descrivete, osservate, provate a mettervi nei loro panni e vivete con cuore puro e mente aperta. Vivete.
Nadiya Najim
Nel gelido prato
- Dettagli

In data 8 ottobre 2016 si è tenuto uno spettacolo teatrale per gli studenti dell'Istituto Beretta sulla violenza sulle donne, “Gelido prato”, finanziato dalla Civitas e messo in scena dall'associazione culturale Treatro – terrediconfine. Lo spettacolo era l'esito di un laboratorio della durata di quindici incontri, aperto a donne e uomini di maggiore età. Basato sul libro Ferite a morte di Serena Dandini, lo spettacolo ha toccato tutte le sfumature del tema “violenza sulle donne”, dalla violenza psicologica a quella fisica; un ammonimento rivolto soprattutto ai giovani, gli adulti di domani, un'esortazione – o meglio, la richiesta di aprire gli occhi su quella che è una realtà sempre attuale, una realtà che non sempre si ha il coraggio di rivelare, nonostante aleggi tra di noi come un fantasma letale, tra le mura di casa nostra e negli occhi vuoti di donne troppo spaventate per fidarsi della nostra società.
Uno spettacolo crudo e diretto, che rivela dati e avvenimenti reali con un sottile filo ironico necessario a far aprire gli occhi dallo sbigottimento e far correre brividi di inquietudine, ma con la leggerezza.
Lo spettacolo si apre con una sfilata di donne, tutte diverse fra loro tra età e aspetto fisico, intente a mostrare il loro lato migliore con sensualità e un po' di civetteria, sotto gli occhi scrutatori di due uomini che le valutano come merce in vendita. Una scena che descrive con tocco ironico come vengono viste le donne nella società odierna, giudicate superficialmente in base al loro aspetto fisico e alle loro capacità.
“Siamo donne. È il nostro destino. Non possiamo farci niente.” è il messaggio che emerge nelle scene successive. Senza lasciar il tempo allo spettatore di riprendere fiato vengono raccontati episodi di vergogna, dedizione, morte e amore da donne che non si capacitano della brutalità e della violenza degli uomini che hanno amato con passione e da cui sono state uccise. Padri, mariti, amanti, vicini di casa, tutti colpevoli di omicidio e omertà. Una rapida successione di parole e gesti che scombussolano e catturano lo sguardo dello spettatore, che diventa complice e partecipe.
Le donne non se lo aspettano. Forse se lo vanno a cercare, per come si vestono, per gli uomini che si trovano, perché non si ribellano. Non se lo aspettano, avviene tutto così all'improvviso, in un battito di ciglia, e l'uomo dolce e premuroso che le ha protette diventa l'incubo da cui fuggire. “Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorte!”. Decisioni sbagliate di uomini non del tutto consci delle loro azioni. Uomini che non sono né “buoni” né “cattivi”. Giusto, sbagliato, bene e male, sono solo preconcetti che illudono, ma non giustificano le nostre scelte, che spettano solamente a noi. Lacrime di rimorso versate sui corpi freddi di donne che hanno amato con dolcezza e fragilità, fredde confessioni di omicidio di uomini che con impassibilità hanno distrutto sogni e speranze. Le donne non se lo aspettano. Loro perdonano, si illudono, sperano. Sono disposte a sacrificare tutto per il loro uomo: la famiglia, gli amici, il lavoro, le passioni. Loro donano se stesse, chiedendo in cambio di essere amate. Tentano di mascherare la violenza, non si aspettano la morte. “Le donne sono forti, meno che con gli uomini.”
Ed è la loro dolce fragilità a raccontare le loro storie agghiaccianti, il loro amore e i loro sogni. E le loro parole arrivano a chi è disposto ad ascoltare con l'animo sensibile e il cuore aperto. “Fa che queste mie lacrime, questo pianto ti onori, questo vaso di latte, questa cesta di fiori, e il tuo corpo non sia, vivo o morto, che rose”.
La testimonianza di una delle attrici, Nadiya Najim:
Devastante. Sensuale. Forte. Bella. Agghiacciante. Dolce. Commovente.
Sono tanti gli aggettivi che potrei usare, ma questi sono quelli che meglio descrivono la mia esperienza di attrice nel “Gelido prato”, laboratorio teatrale sulla violenza sulle donne (seguito poi dall'esito che abbiamo replicato una decina di volte). Vivere questo progetto dall'interno è stato unico e indimenticabile, che ha lasciato un segno indelebile sulla mia formazione di giovane donna e attrice. Il nostro scopo era far aprire gli occhi a persone in grado di cambiare la nostra realtà, quella realtà che nasconde violenza fisica, sessuale e psicologica dietro a un sorriso rassicurante, occhi pieni di lacrime, fondotinta e cerotti. E quelle persone sono proprio i giovani. Non era necessario che capissero tutti: se anche un solo giovane avesse recepito il messaggio che volevamo trasmettere, ci saremmo sentiti soddisfatti, ma il risultato è stato di gran lunga meglio del previsto e noi non possiamo che gioirne. Avevamo l'arduo compito di raccontare storie di morte e violenza senza risultare vittime bisognose di aiuto e compassione; dovevamo parlare di ferite letali con leggerezza, dolcezza ed ironia, senza pressione, senza forzare. Dopotutto, è un argomento fragile, che ha bisogno di essere trattato con la dovuta delicatezza. E tra parole, poesie, danze, gesti, carezze, racconti, dati e petali di rose abbiamo raccontato di Marie, uccisa dal suo amante per gelosia; siamo state Teresa, che con la faccia viola di pugni raccontava sorridente di essere caduta dalle scale della cantinetta; eravamo Ivana, che attraverso la fredda confessione del suo fidanzato Giovanni ha espresso il suo disappunto per essere stata soffocata da un tovagliolo rosso a causa di una risposta non gradita; e in noi c'era quella giovane commessa di intimo strozzata con delle mutandine di pura seta perché le piaceva un po' di violenza a letto, le piaceva sentirsi un po' schiava e un po' geisha, ma il compagno non è riuscito a fermarsi; abbiamo parlato con la voce di Hamina, sgozzata dal padre perché voleva cambiare una storia già scritta e sposare un uomo diverso da quello a cui era destinata. Ma chi eravamo? Eravamo donne. Eravamo Vittoria, Elena, Alessia, Barbara, Nadia, Adriana, Rossana. Ognuna con le proprio passioni, con la propria vita e con i propri sogni, ma ci siamo prese il carico di denunciare una scomoda verità per un futuro meno inquietante. Per un mondo dove le donne possono vestirsi come piace a loro, senza esser poi incolpate di aver provocato il loro stupratore. Dove tutti possono dire la loro, senza aver paura di una risposta troppo violenta. Dove ognuno può essere se stesso senza essere giudicato. Un posto dove donne e uomini possono vivere sereni con i loro interessi, le loro passioni, i loro sogni e le loro ambizioni. Senza paura che l'amore della tua vita si riveli un mostro brutale e violento. E sarebbe più semplice se si potesse trovare il coraggio di denunciare una situazione di violenza senza avere il terrore di essere uccisi.
E se ognuno di noi si impegnasse a prendersi carico di questa cruda verità, forse questo non sarebbe più un mero sogno di poche persone fiduciose e speranzose, ma una realtà.
La via d'acqua...analizzare, studiare, ricostruire il territorio
- Dettagli

Gli alunni della classe 2A sono stati coinvolti in un progetto per il raggiungimento di competenze ambientali di cittadinanza attiva. Hanno studiato la geologia, la storia, la sociologia, la botanica che hanno caratterizzato gli insediamenti nati lungo il fiume Mella. Un'indagine che si integra con le nuove infrastrutture che il Comune di Sarezzo ha creato proprio ul letto del fume. Perchè indagare l'ambiente che ci circonda ripercorrendone la sua storia, riscrivendo i documenti che lo vedono protagonista di sfruttamento e abusi? Perchè il presente si può comprendere solo leggendolo nelle righe del passato e attraverso linguaggi diversi: geografico, cartografico, scientifico e storico, per questo le prof.sse Fracassi, Di Gregorio, Luscia e il prof. Gobbi hanno seguito con esperti esterni i ragazzi in questa presa di consapevolezza per vivere il loro territorio.
70 anni di scelta democratica
- Dettagli
 Per ricordare i 70 anni di scelta democratica al referendum del 1946 gli alunni delle classi terminali di ITIS - LICEO E IPSIA si sono fatti accompagnare da una lezione storica tenuta dalla sezione ANPI di Gardone V.T. nelle persone del prof. Ceretti e del prof. Bonetti.
Per ricordare i 70 anni di scelta democratica al referendum del 1946 gli alunni delle classi terminali di ITIS - LICEO E IPSIA si sono fatti accompagnare da una lezione storica tenuta dalla sezione ANPI di Gardone V.T. nelle persone del prof. Ceretti e del prof. Bonetti.
Perchè una giornata dedicata a questo tema con laboratori in aula e conferenze? Perchè i diritti non sono mai un dato acquisito, ma la meta di un cammino di cittadinanza attiva che i nostri studenti devono ripercorrere per essere votanti e cittadini attivi e consapevoli a loro volta.
Segui su Campus i contributi a questa giornata
Progetto Chioccolamente
- Dettagli
Il progetto di rete CHIOCCOLAMENTE svoltosi tra l'Istituto Beretta, l'IC di Bovegno e l'IC di Orzinuovi nella sezione di Pompiano ha la conoscenza dell'avifauna alpina e l'arte del chioccolo in un percorso teorico e pratico sovvenzionato dalla sezione bresciana dell'associazione Federcaccia. Il percorso si è concluso con un test selettivo grazie al quale 15 alunni dei tre diversi istituti accompagnati dalla prof.ssa Silvia Luscia, dal maestro di chioccolo Loris dal Maistro e dal commissario provinciale Romano Bregoli hanno vissuto un week end intensivo per imparare a chioccolare e conoscere le peculiarità dell'avifauna alpina. Il week end ha messo in contatto gli alunni con la tradizione casearia locala, ha previsto passeggiate per la valorizzazione della flora e il bird watching legato al codirosso e alla parata d'amore del gallo forcello. Socializzazione e integrazione con l'ambiente alpino per vivere attivamente l'ambiente valligiano.
Da fruitori a collaboratori...mostra Vita del Bosco
- Dettagli

All'interno del progetto Chioccolamente intrapreso per la valorizzazione dell'avifauna valligiana e la conoscenza consapevole della tradizione venatoria locale, gli alunni della classe 1A ITIS da frituri del musoe gardonese sono diventati attivi collaboratori all'interno della mostra VITA DEL BOSCO. Garzie a percorsi multimediali rielaborati da Contin Mattia, Santina Giovanni e Gnutti Andrea la cittadinanza potrà ricostruire la storia dell'arte venatoria dalla preistoria all'invenzione dei roccoli, riscoprire il mito della dea Diana attraverso opere d'arte contemporanea e riflettere sulle diverse strumentazioni venatorie anticipatrici delle armi da fuoco. Partecipare alla storia della comunità per interpretarla e saperla innovare consapevolmente grazie ad una lettura critica e inclusiva del territorio.
Progetto carcere
- Dettagli

Nel giorno del ricordo del sacrificio di Giovanni Falcone per il rispetto della legalità, gli alunni della 5A -5B-5D del plesso ITIS hanno condiviso la riflessione legata appunto al senso della legalità oggi con i detenuti e le detenute del carcere di Verona. Un incontro con un'alterità che mantiene la sua umanità, l'incontro con la presa di coscienza dello scarto tra reato e persona che lo commette, l'incontro con la responsabilità del nostro essere cittadini attivi riscoprendo il valore delle regole che tutelano la nostra convivenza.
In cammino sul sentiero Moretti
- Dettagli
 Sabato 7 maggio alcuni alunni della 1 a itis si sono recati accompagnati dai volontari ANPI di Gardone V.T. a omaggiare la stele del giovane partigiano Moretti dopo aver perorso il sentiero che ha guidato i passi del giovene fino alla morte.
Sabato 7 maggio alcuni alunni della 1 a itis si sono recati accompagnati dai volontari ANPI di Gardone V.T. a omaggiare la stele del giovane partigiano Moretti dopo aver perorso il sentiero che ha guidato i passi del giovene fino alla morte.
Non solo vivere, ma anche voler valorizzare il territorio con un progetto di rivalutazione storica del percorso...un obiettivo da non disattendere il prossimo anno
Collaborazione scuola - famiglia che crea cittadinanza attiva
- Dettagli

Il 3 febbraio noi alunni della classe 2a abbiamo ascoltato la testimonianza della madre del nostro compagno, la signora Sanga Pedersini, e abbiamo compreso ciò che è stato il regime romeno. Abbiamo capito che conoscere è integrare.
Nell’ultimo periodo del nostro cammino scolastico, in italiano, noi alunni della 2 A a indirzzo meccanico abbiamo visto e abbiamo studiato l’orrore delle diverse dittature, anche con testimonianze delle esperienze personali raccontate dalla mamma di Enrico che è venuta in classe e con il suo fantastico entusiasmo ci ha raccontato la sua storia, la sua infanzia al tempo del regime di Ceausescu, grande dittatore rumeno. Analizzando attentamente ogni storia che tratta di discriminazione troviamo moltissime somiglianze con le autocrazie del giorno d’oggi. Noi abbiamo trattato e approfondito quella in Siria. La situazione in quel Paese è davvero critica perché ogni giorno muoiono tantissime persone, anche innocenti. Abbiamo riflettuto molto soprattutto perché avvertiamo un senso di impotenza, loro non hanno diritto di parola come succedeva in Europa nei paesi sottomessi al nazismo di Hitler duramente espresso nel film “La Rosa Bianca” dove i due fratelli Scholl vengono arrestati, messi in carcere e successivamente uccisi perché non erano a favore del regime nazista. Nella potente Germania degli anni ’40’ ai erano formati campi di concentramento dove vi venivano inserite innumerevoli persone, trattate come animali, senza alcun ritegno, con il numero di identificazione tatuato sul braccio. La vita all’ interno del campo non era facile, come raccontato dal colonnello Melvin, inorridito e sconvolto dal non poter aiutare queste povere persone, senza un’identità, senza speranza di vita, come ancora succedeva durante la dittatura Jugoslava con Tito che operava stermini di massa contro gli italiani mettendo la gente indifesa e senza alcun diritto umano nei campi di coercizione e successivamente gettate nelle foibe dove trovavano una morte atroce e dolorosissima. Come ho detto all’inizio, purtroppo, queste situazioni esistono ancora al giorno d’oggi e si sta facendo il possibile per eliminare le forme di dittatura, ma fino ad ora con pochi successi. Nel nostro piccolo non possiamo fare molto, ma possiamo accogliere ed aiutare persone in difficoltà anche se di nazionalità diverse perché siamo tutti uguali e abbiamo tutti gli stessi diritti, primo fra tutti quello alla vita e alla libertà personale
( Michele Bersini 2A)
Cosa è satato il regime di Ceausescu di cui la signora Sanga Pedersini ha vissuto contraddizioni speranze e asprezze?
Abbiamo rielaborato illa testimonianzadella signora Sanga Pedersini in un racconto.
ASCOLTANDO ADRIAN PAUNESCU’
Il giradischi suonava Adrian Paunescù, Marian fumava una sigaretta reclinata sulla poltrona, mentre le parole di “ Ruga pentru parinti” riempivano la stanza e si tuffavano nel caffè ormai freddo accanto a lei. Aspirava e guardava il fumo uscire lentamente dalla bocca ricamando i suoi ricordi. Adrian Paunescù, poeta, scrittore e cantante era stato la voce della libertà del popolo rumeno e Marian ricordava quando nel 1973 con migliaia di giovani affollava i suoi concerti dove lui e altri suoi seguaci presentavano opere musicali e letterarie contro il potere comunista. Un impegno e una resistenza costanti fino ai primi disordini del 1985 e alla definitiva rivoluzione dell’’89. Quando la voce di Paunescù raggiungeva Marian e suo fratello Costantin in quegli assembramenti della speranza, la sensazione che li invadeva era che qualcosa stava cambiando, nonostante le strade pattugliate, il carcere punitivo per dissidenti e disoccupati e la fame. Non hanno portato la rivoluzione i minatori di Maramures, lo sapeva bene Marian oggi, ma le poesie di Adrian e la tenace cultura della libertà che il regime non ha mai potuto e forse voluto schiacciare.
“ Fate una carezza ai vostri genitori” gracchiava il giradischi. I suoi genitori, Marian aveva avuto un padre alcolizzato che, indebitando e abbandonando la sua famiglia, aveva lasciato alla moglie Maria la responsabilità dei figli. Lei era il genitore a cui Marian oggi faceva una carezza ad occhi chiusi. Lei, una minuta cuoca di Caransebes, che aveva visto il susseguirsi di diverse monarchie in Romania fino ad arrivare a quella di re Mihai esiliato nel 1947 con l’avvento della repubblica socialista rumena, guidata dal primo capo comunista Gheorghe Gheorghiu – Dej. Maria aveva conosciuto da vicino la classe dirigente del partito quando a dodici anni fu accolta in casa del direttore del penitenziario di Caransebes, non come una figlia, ovviamente, ma come una serva. La madre di Maria era all’epoca molto malata e nessuno avrebbe potuto badare a lei. Era il 1942, la guerra imperversava nell’Est Europa e Ceausescu veniva imprigionato proprio a Caransebes. Quando Maria terminava i lavori domestici in casa del direttore aveva il compito di distribuire cibo ai detenuti del penitenziario e fu lì che quella bambina conobbe, amò e portò del cibo trafugato e nascosto nei suoi vestiti a un giovane calzolaio rivoluzionario, per più di un anno fino al trasferimento dell’uomo in un altro carcere. Era Nicolae Ceausescu. Passarono circa otto anni quando Ceausescu, ormai uscito di prigione e divenuto un importante membro del partito, ritornò a Caransebes come promotore di varie attività sociali legate al partito. Si recò di pomeriggio alla “ Cantina Regionala” del partito locale dove Maria faceva la cuoca in quanto moglie di un attivista politico. Fu in quell’occasione che Nicolae la riconobbe. Non valsero le di lui insistenze perché lo seguisse a Bucarest dove già sapeva che sarebbe diventato un politico importante per la nazione. Maria restò, lei sapeva che stava per diventare madre. Non sapeva però che proprio la sua seconda maternità l’avrebbe costretta a una lunga malattia, sola con i suoi figli, col solo supporto del fratello di Marian, Costantin. I debiti del marito e le ingenti spese per le cure costrinsero Maria a vendere la sua casa di proprietà a Caransebes e a spostarsi fino ad Arad per cercare presso conoscenti un alloggio e attraverso le liste di occupazione ottenere un lavoro. L’alloggio di Arad per dieci giorni fu un albero all’interno di un cortile condominiale, un albero ricoperto con dei teli cerati. Fu uno zingaro commerciante di vetro che alloggiava con i suoi dieci figli nel loro stesso cortile a costruire anche per Maria e la vecchia ebrea ungherese Ildiko, scampata ai rastrellamenti del ’43, alcune stanze abusive. Quella fu la casa di Marian fino alla sua partenza dopo la rivoluzione, quando aveva ormai vent’anni, un amore con cui partire e un fratello morto nella rivoluzione. Da quelle stanze Marian vedeva il grande condominio in cui le persone dovevano riscaldare gli edifici con temperature comprese tra i 5 e i 12 gradi e questo significava che chi come l’infermiere Alexadreu abitava gli ultimi piani, non aveva nemmeno il minimo di riscaldamento, quando la temperatura esterna scendeva oltre i dieci gradi sotto zero. Marian ricordava ora il freddo di quegli inverni e la mancanza di luce elettrica la sera per imposizione del governo. Solo la fame loro non avevano patito. Maria infatti ad Arad era diventata commerciante e aveva contatti con gli agricoltori della zona. Lei vendeva i loro prodotti e loro le davano cibo in più per i figli. Diversamente alimentari di prima necessità come latte, frutta, olio, zucchero e carne non erano reperibili facilmente e quando erano disponibili venivano acquistati con buoni mensili. E questo comportava lunghe file fuori dai negozi, rischi di risse e umilianti mance di sottobanco ai negozianti. Perché tutto questo in una nazione dalla fiorente agricoltura? Perché in Romania tutti i prodotti venivano quasi interamente esportati e la merce di importazione era molto limitata. Le famiglie del cortile condominiale non avevano automobili, si usavano i carri, anche per il trasporto di vetro del commerciante zingaro, ma tutti sapevano che la benzina era razionata e pochi potevano acquistarla coi buoni mensili.
Maria era cattolica, ma ben presto aveva smesso di praticare la sua fede, in quelle domeniche rumene. Il partito dava direttive per eliminare tutte le chiese di qualsiasi culto religioso, infiltrando agenti segreti che monitorassero non solo le attività, ma i pensieri, gli sfoghi stessi dei fedeli che si illudevano di poter godere di una libertà di pensiero all’interno di una chiesa. Maria aveva paura che la Securitate potesse danneggiare la sua famiglia e così barattò la consolazione di Dio con il silenzio della sopravvivenza. Solo a una cosa Maria non aveva rinunciato, alle telefonate con un’amica d’infanzia che si era trasferita negli Stati Uniti. Le telefonate erano controllate, Maria lo sapeva, e così avevano imparato a parlare con un codice loro. Il regime non tollerava che si diffondessero all’estero notizie relative a quello che succedeva in Romania e per questo le chiamate internazionali erano limitate. Le telefonate si concludevano sempre da parte statunitense con la medesima espressione “ qui il vino è buono” che ha la stessa pronuncia, ma scrittura diversa di “ Non torno più in Romania”. Per chi restava questa frase acuiva il senso di condanna e impotenza per la propria condizione. Ad andarsene era la speranza. Sorrideva Marian ora a quest’ultimo ricordo. Stati Uniti e speranza che se ne va. Sorrideva perché le venne alla mente Nadia Comaneci che durante la rivoluzione fuggì negli Usa e Nadia in russo significa speranza. Nadia aveva fatto sperare e sognare migliaia di rumeni ai giochi olimpici e se una Romania grande c’era stata sotto il regime, bene, quella era incarnata in Nadia Comaneci. Lo Stato l’aveva riconosciuta come eroe del lavoro socialista nel 1976, il popolo l’aveva riconosciuta come l’attuazione di un sogno di rivalsa davanti al mondo intero. Questo per Marian faceva la differenza tra la riconoscenza della politica e la gratitudine di un popolo. La sigaretta era terminata, Marian faceva frusciare tra le dita le vecchie fotografie di suo fratello quando bambino recitava al Teatrul de Stat de Arad sotto la direzione di Doina Marinescu, quando erano giovani studenti. Le teneva impacchettate sulla scrivania. In una fotografia lei e Costantin si tenevano per mano in divisa, lei in gonna e camicia bianca e lui con pantaloncini e camicia e un foulard per tutti rigorosamente di colore rosso. La consegna del foulard era il rito che i bambini del quarto anno compivano per entrare nel mondo comunista. Già nelle scuole si inculcava la necessità di una società gerarchizzata secondo il modello militare. Venivano nominati dei capigruppo ogni cinque alunni, Costantin era stato uno di loro, poi veniva nominato un altro capo per ogni cinque classi ed infine un capo d’istituto per il controllo totale. Ognuno di loro doveva rapportare ai dirigenti scolastici ogni attività e momento di socializzazione dei gruppi studenteschi. Grazie ai meriti di Costantin nell’arte teatrale venivano loro concesse due vacanze annuali, una al mare e una in montagna. Suo fratello aveva sempre riservato a lei una delle due occasioni di vacanza, era diventato un padre per lei e si sentiva finalmente protetta. Una fotografia sbiadita la ritraeva con una grossa borsa di ortaggi. Durante la frequentazione della scuola media e superiore il regime obbligava gli studenti una volta all’anno per tre settimane ad andare sui campi per la raccolta di ortaggi a favore dello Stato. Il premio finale per ogni studente partecipante era proprio una borsa colma del raccolto. Oggi quella borsa per Marian era colma di memorie. Ogni volta quegli ortaggi venivano divisi con i vicini di cortile, con la vecchia ebrea Ildiko e quell’anno fu l’ultimo per lei. Un’immagine la fotografava ormai senza denti seduta su uno sgabello posto sopra un telo bianco. Serviva per i pidocchi. Nessuno voleva Ildiko in casa propria, solo la madre di Marian le offriva compagnia e assistenza in cambio dei suoi ricami a uncinetto. Ricamava, ricamava sempre e all’aperto. Un giorno Ildiko disse a Maria: << Quando sarò morta, non bruciarmi. Ti prego non permettere che mi brucino>>. Maria mantenne la promessa. Quando la vecchia ebrea morì lei non permise che le autorità la bruciassero insieme alla sua casa ridotta a un cumulo di sporcizia e roditori tra bianchi merletti d’uncinetto. Maria avvolse il corpo nudo di Ildiko in un bianco lenzuolo lo consegnò al rabbino della sinagoga di Arad e pagò le esequie. Ora la vecchia ebrea riposava in un cimitero annesso alla sinagoga. Non era stata bruciata.
Le fotografie scrocchiavano ingiallite passando tra le dita di Marian. Le scostò per un momento e posò su un articolo del Guardian di Alaa Abdel Fattah, un blogger egiziano imprigionato dopo la caduta di Mubarak e il massacro di Rabaa. Anche lui stava combattendo per la libertà del proprio paese, anche lui come Costantin era un figlio della rivoluzione e non era ingenuo il suo credere che il sogno della libertà si sarebbe potuto avverare. Marian stava scrivendo un reportage su di lui, un racconto di un resistente della narrazione e sperava non di un altro martire della rivoluzione. Anche la Rivoluzione romena del 1989 fu un insieme di proteste violente come quelle egiziane e se negli altri Paesi del blocco comunista dell'Europa orientale il passaggio alla democrazia avveniva in quegli anni in modo pacifico, in Romania le manifestazioni si erano fatte sempre più volente, fino a raggiungere il culmine con il processo e l'esecuzione di Ceausescu e della moglie Elena. Costantin era partito da Arad col nastro rosso al braccio sinistro per Timisoara il 16 dicembre del 1989. Non era più tornato. Sua madre aveva pianto a lungo, e oggi quel dolore ricordava a Marian lo strazio di Layla Marzooq Al Sayed, madre di Khaled Said, torturato e ucciso dalle forze armate quando lei lavorava in Siria nel 2010. Continuavano intanto a scorrerle davanti agli occhi i fotogrammi di quelle giornate convulse del1989. Petre Roman che parlava alla folla di Bucarest, la bandiera forata della rivoluzione, Ioan Iliescu sui canali televisivi, i convogli militari assaltati dai rivoluzionari. E infine la fucilazione di Nicolae ed Elena Ceausescu la notte di Natale nella prigione di Targoviste. Sua madre Maria non aveva voluto vedere le immagini dell’esecuzione, mai. La rivoluzione le aveva strappato un figlio e quel calzolaio rivoluzionario che si portava in corpo il pane trafugato della sue colazioni. Marian riaccese la sigaretta, aspirò, chiuse gli occhi e si lasciò invadere dalle note di Adrian Paunescù .
Prof.ssa Silvia Luscia